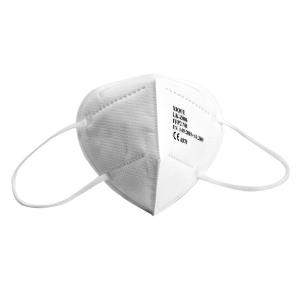La mascherina: dal medico della peste ai modelli chirurgici moderni
Dalle epidemie del passato alle sale operatorie contemporanee, la mascherina è uno degli oggetti simbolo della medicina. La sua forma è cambiata nel tempo, ma il suo scopo è rimasto coerente: proteggere.
Il medico della peste e la maschera “a becco”
Il concetto di mascherina chirurgica, così come lo conosciamo oggi, nasce verso la fine dell’Ottocento. Ma già durante il XVII secolo nacque un oggetto che fu di grande ispirazione per i dottori futuri: la maschera a becco.
In quegli anni, l’Europa era scossa da terribili ondate di peste bubbonica e i cosiddetti “medici della peste” erano le figure incaricate di soccorrere e curare i malati.
Questi personaggi erano facilmente riconoscibili grazie al loro abbigliamento caratteristico: lunga tunica cerata, cappello, bastone per mantenere le distanze e soprattutto maschera dalla cosiddetta forma a becco.
In un certo senso questi abiti erano i primi veri e propri dispositivi di protezione, pensati per creare una barriera contro i “miasmi”, cioè i cattivi odori ritenuti responsabili della trasmissione delle epidemie. I dottori si proteggevano inserendo all’interno del becco erbe aromatiche, spezie e panni imbevuti di aceto. Con l’avvento della medicina moderna sappiamo che queste tecniche non garantivano una protezione reale, ma rappresentarono comunque il primo tentativo strutturato di difesa personale del medico in contesto epidemico.
Dalla teoria dei germi alle prime mascherine moderne
Un primo progresso significativo arrivò in seguito al consolidamento della teoria dei germi di Pasteur e Koch. Grazie ai loro studi, la medicina iniziò a riconoscere che i batteri e gli agenti patogeni sono in grado di viaggiare attraverso l’aria, veicolati dalle particelle di saliva.
Per questa ragione, nel 1897 il chirurgo francese Paul Berger introdusse in sala operatoria una mascherina in garza multipla per ridurre il rischio di contaminazione del campo sterile.
Il XX secolo: la mascherina entra nella pratica clinica
Con il progredire della chirurgia e delle conoscenze sulle infezioni ospedaliere, la mascherina è diventato un accessorio standard nella routine medica. I primi modelli realizzati in tessuto, lavabili e riutilizzabili, hanno gradualmente ceduto il passo ai dispositivi monouso, sicuramente più igienici e performanti.
Negli anni ’70 hanno iniziato a diffondersi i materiali non tessuti (TNT), come il polipropilene, che hanno permesso di produrre mascherine leggere, efficienti e a basso costo.
Con le nuove tecnologie, la barriera protettiva è diventata sempre più efficace nel filtrare droplet e aerosol, mentre gli standard normativi hanno iniziato a definire criteri precisi per filtrazione, traspirabilità e resistenza.
Dalle chirurgiche alle filtranti: nuove generazioni di protezione
Oggi distinguiamo chiaramente due grandi categorie:
- Mascherine chirurgiche
Pensate per proteggere l’ambiente e il paziente dall’emissione di droplet da parte dell’operatore. Sono dispositivi medici e seguono la normativa EN 14683, che definisce tre livelli di filtrazione (Type I, II e IIR).
- Mascherine FFP
Progettate per proteggere chi le indossa, filtrano l’aria inspirata e sono classificate come DPI secondo la normativa EN 149 (FFP1, FFP2, FFP3). Sono fondamentali in contesti ad alto rischio biologico, in terapia intensiva, durante procedure invasive o in ambito industriale.
La pandemia di COVID-19: un ritorno sotto i riflettori
In molte metropoli asiatiche, le mascherine fanno parte della quotidianità da tanti anni: le indossa gran parte della popolazione, sia per proteggersi dall’inquinamento sia per ridurre la diffusione di raffreddori e infezioni stagionali.
Dal 2020 questa abitudine è entrata a far parte anche delle nostre vite: la mascherina è diventata un oggetto quotidiano per miliardi di persone. La sua adozione su larga scala ha riportato l’attenzione sul valore della prevenzione e ha accelerato l’innovazione: dai materiali più efficienti ai modelli trasparenti, dalle mascherine antibatteriche a quelle lavabili certificate.
La pandemia ha anche fatto emergere l’importanza di una corretta informazione sull’uso appropriato dei dispositivi, distinguendo tra contesti sanitari, comunitari e professionali.
Sebbene la situazione ad oggi sia tornata alla normalità, la ricerca sta continuando a lavorare a soluzioni sempre più sofisticate: filtri intelligenti, materiali biodegradabili, dispositivi integrati con sensori, mascherine più ergonomiche e più sostenibili. Ma la direzione è chiara: ridurre l’impatto ambientale senza comprometterne l’efficacia.